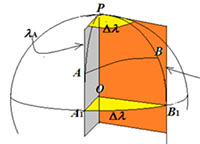Costruita nel 1921 come Gloxinia a Tyne Iron SB Co in UK di 3336 tons. Nel ’52 diventa Vittoria O. per la società Imera Siciliana di Navigazione di Palermo; nel ’55 passa alla Società Armamento Marittimo srl di Genova sempre come Vittoria O. Demolita alla Spezia il 3 aprile ’59 ai Cantieri Navali Santa Maria.

La “Antonio Gaudino”, nave gemella della “Vittoria O.”
Ci sono onde che mai nessuno è sopravvissuto per raccontarle
Essendomi prefisso di scrivere tutto quello che mi veniva in mente senza ordine cronologico, in questo momento voglio raccontare un episodio che mi capitò durante una traversata atlantica nell’aprile 1958.
Anzi, adesso che ci penso questo avvenimento si può “collegare “ al mistero della religione, in quanto esso viene evidenziata la differenza del comportamento di un credente e quello di un miscredente bestemmiatore incallito.
Con un carico di carbone proveniente dalla Virginia si navigava da qualche giorno verso l’Europa, quando ci imbattemmo in un terribile ciclone, che a detto dei vecchi naviganti lasciava ben poche possibilità di uscirne fuori indenni.
In poco tempo ci trovammo in un inferno impossibile a descriversi. La nave era una vecchia carretta di undicimila tonnellate, uno dei modelli che l’America aveva costruito in serie durante la guerra e che perciò erano dai naviganti considerate poco sicure specialmente per le attraversate atlantiche.
Si può facilmente immaginare in quale stato d’animo si affrontava una tempesta di quelle proporzioni, in cui la forza del mare é al massimo e in ognuno di noi, giovani e vecchi, sapeva che le possibilità di salvezza erano molto scarse. Personalmente mi terrorizzava il pensiero del modo in cui sarei morto e non la morte in se stessa.
La nave incominciò subito a rullare paurosamente ed io ero in sala macchine insieme ad un ufficiale. Eravamo in due per ogni servizio.
Per fortuna ero occupatissimo a controllare le macchine e a svolgere tutte quelle operazioni ordinarie estraordinarie che in quel caso si devono eseguire con tutto l’impegno e la coscienza che il momento voleva. Ero consapevole che per buona parte la nostra vita e del restante equipaggio dipendeva dalla mia attenzione e capacità, in quanto se per qualsiasi motivo le macchine si fermavano eravamo persi inesorabilmente.
La sola speranza, perciò, era quella dell’efficenza delle macchine per poter tenere testa alla forza del mare navigando “con la cappa al mare“, come si dice in gergo. Ciò voleva significare che la prua della nave doveva andare contro la direzione del ciclone per non essere sopraffatti nel giro di qualche minuto. Tutte le operazioni inerenti al funzionamento delle macchine erano eseguite manualmente, compresa la lubrificazione degli elementi in movimento. In quel caso tutte le macchine, specialmente quella principale che era alternativa e tre cilindri a vapore, erano sottoposte ad uno sforzo fuori del comune. Sarebbe bastata, perciò, una qualsiasi rottura per mettere a repentaglio la vita di tutti noi.
Facevo una fatica fisica non indifferente per stare in equilibrio e svolgere le attività necessarie, dato che il rullio della nave era incessante.
Fino a quando non terminai il mio turno di servizio non potei vedere quello che realmente stava accadendo intorno a noi, e quindi non ebbi eccessiva paura. E poi non ne avevo il tempo. Quando smontai, dopo quattro ore, andai nel ponte sottocoperta in una saletta dove erano raccolti i miei colleghi non in servizio e fu lì che ebbi veramente paura.
Guardando in faccia quegli uomini lessi il terrore nei loro occhi e mi resi conto della reale gravità della situazione. I volti tirati di colore giallognolo e il silenzio della morte che regnava in quel luogo mi sconvolsero per un momento anch’io divenni di pietra come loro. Mi sedetti in un angolo appoggiato ad una paratia e me ne stetti in silenzio per un tempo che fu un’eternità, senza neanche pensare, evitando di guardare gli oblò per il timore di vedere quel mostro scatenato che era il mare in quel momento.
La parete esterna con cui la saletta confinava era battuta di tanto in tanto da onde così violente che sembrava dovesse fracassarsi da un momento all’altro; il mio cuore batteva al ritmo di quei tremendi colpi.
Un solo attimo, e mi trovai a pensare a quale sarebbe stato il colpo che avrebbe abbattuto quella parete. Subito dopo, a poco a poco il pensiero si distolse da quella eventualità e volò come impazzito verso i miei cari, a casa mia.
A occhi aperti vidi, come nella pellicola di un film che girava vertiginosamente, tutte le cose del mio passato confuse col presente. Non so descrivere quanto durarono queste visioni, nè quello che vidi in quel film, ma credo di poter affermare che quello che mi successe é quello che succede a tutti gli uomini che, persa ogni speranza, si trovano di fronte alla morte coscienti e rassegnati.
In seguito sopravvenne come un senso di incoscienza, ero privo di ogni paura, totalmente abbandonato in attesa che avvenisse quello che ormai pensavo fosse inevitabile. Col passare delle ore, però mi risvegliai da quel tepore e volli avere speranza… e volli vivere.
Cominciai a guardare con un occhio diverso i miei compagni di sventura, li osservai con più attenzione e li trovai più umani di quanto non li sapessi prima. Li sentii più fratelli, volevo loro bene come non mai. Potei vedere solo allora come molti di loro erano realmente. Scoprii che gli uomini in prossimità della morte o in pericolo di vita si trasformano e non sono più quelli di prima, sono diversi, sono se stessi, sono soprattutto più buoni.
Di fronte a me sedeva Pasquale – ricordo solo il nome – appoggiato con le braccia sul tavolo, assorto in non so quali pensieri. Il suo volto mostrava segni di stanchezza ed era come inebetito, i suoi occhi erano fissi in un punto, potrei dire nel nulla. Chissà da quanto tempo era in quelle condizioni, pareva mummificato. Pasquale era un uomo sui quarant’anni e a bordo svolgeva mansioni di fuochista come me. Subito dopo l’imbarco ci eravamo trovati a spartire la stessa cabina, la mia cuccetta era sopra la sua. Lì per lì fui contento di averlo nella mia cabina, pensando che sarei andato d’accordo con lui perché l’avrei trattato come un padre. Pensavo che da lui avrei imparato tante cose interessanti, data la mia giovane età.
Un uomo come lui doveva aver fatto sicuramente un gran bagaglio di esperienze navigando per tutto il mondo, e io, perciò, con tanto desiderio di sapere, mi sarei arricchito della sua esperienza. Ma sentivo soprattutto il bisogno di avere un amico con cui scambiare qualche parola durante le lunghe traversate o nei momenti in cui si sente la lontananza dalla propria terra e dalla famiglia.
Purtroppo ebbi una grossa delusione: quell’uomo si dimostrò subito un orso, introverso e scontroso. Tutti i miei tentativi per creare un dialogo fallirono ed egli, oltre che non accettarlo, quando apriva bocca per dire qualcosa era un vulcano che sputava parolacce e bestemmie contro tutti e tutto.
A volte entrava in cabina come se io non ci fossi stato e farfugliava frasi incomprensibili, ma soprattutto bestemmiava. Io ormai, dopo gli inutili tentativi, non facevo più caso a quello che diceva e a quello che faceva, per me quell’uomo era un mistero. Doveva essere uno di quei tipi che non credono a niente e a nessuno, era sempre appartato e non faceva amicizia con nessuno.
Quel giorno, seduto in quell’angolo, doveva essere in uno stato d’animo particolare, perché qualche minuto dopo, quando entrò un marinaio bestemmiando, questi si alzò in piedi e come fuori di sè inveì contro il bestemmiatore gridando che non si doveva farlo in un momento come quello, ma pregare perché Dio ci aiutasse.
Dacché i presenti,conoscendo che razza di bestemmiatore fosse lui stesso rimasero ammutoliti, compreso io. Vidi quell’uomo trasformarsi in un attimo da lupo ad agnello, tremante di paura e vigliacco. Ipocriticamente invocava Dio perché in quel momento ne aveva bisogno, ma era pronto a rinnegarlo il giorno dopo.
Pasquale fino a quel momento mi aveva fatto un certo senso fatto paura; dopo, per lui sentivo un senso di pietà e di pena.
Quella saletta era un punto di incontro per tutti i giorni. In giorni normale c’era una certa animazione, ma quel giorno c’era un silenzio di morte, se escludiamo il fracasso e il bombardamento del mare contro quella povera carretta, che a quel punto sembrava più una bara galleggiante che una nave. Fra noi c’era il silenzio e soprattutto attesa, attesa di qualcosa che doveva accadere.
Si affacciò alla porta un giovane ufficiale di coperta che con fare falsamente allegro fece qualche battuta spiritosa che non fece ridere nessuno, in quel momento si abbattè sulla murata un colpo che fece rizzare i capelli e vidi il giovane ufficiale impallidire e ammutolirsi.
Poi fu la volta del nostromo, che si fermò un attimo per raccontarci che con una squadra stavano tentando di passare dall’interno della sala macchine al locale timone, ma che la cosa risultava impossibile perchè i bulloni che chiudevano la botola, in disuso da tempo, erano ossidati e il cunicolo che portava alla botola era troppo stretto per poterci lavorare. Inoltre dato che dall’esterno non era possibile arrivare al locale timone perchè rischiavamo di essere spazzati via dalle enormi ondate, c’era il pericolo di un’avaria al timone che sarebbe stata fatale per tutti.
Figurarsi con quale preoccupazione diceva queste cose, e con quale timore noi le apprendevamo. Il nostromo era un vecchio lupo di mare, un siciliano di Catania. Dalla sua espressione si poteva notare che si trovava in una situazione di apprensione e di paura in cui non si era mai trovato prima.
Ricordo che, esprimendosi nel suo dialetto, disse così: “U ventu ‘nt’a Chiesa e va bbene, ma no p’asturari i canneli!” volendo significare che il mare in quelle condizioni era troppo violento.
Se ne andò ripetendo più volte quella frase come se fosse una preghiera.
Le ore trascorrevano lente, nessuno di noi cercava cibo e neppure il letto. E poi il rullio era tale da non consenttirci di muoversi, e di conseguenza erano sconvolte tutte le attività che facevamo normalmente.
Ci fu, poi, il cambio dei turni e venne in saletta un marinaio timoniere. Si sedette in silenzio, ma si vedeva che era completamente sconvolto. Noi guardavamo lui e lui guardava noi senza dire nulla. Avrei voluto chiedergli tante cose, ma non mi andava di parlare. Dopo un po’ di tempo fu lui che iniziò a parlare con noi, ma pareva facesse un monologo perchè non guardava nessuno, perfino i suoi occhi guardavano il nulla.
Disse che aveva fatto la guerra nei sommergibili, che di paure ne aveva avute tante,, la pelle se l’era sempre salvata nonstante tutto, ma questa volta non era sicuro di farcela. Egli dal ponte di comando era stato costretto, attaccato al timone, a guardare il mare che incuteva terrore e un mare come quello non ci avrebbe offerto scampo. Disse che credeva di aver passato nei sommergibili i giorni peggiori della sua vita, ma in quel momento quelle paure erano rose e fiori. Infine disse che se si fosse salvato non avrebbe più navigato.
In quelle interminabili ore tante cose potei capire, di me e degli altri. In un così breve tempo mi parve di invecchiare di un secolo.
Stavamo rintanati sotto coperta come topi in trappola. Volli guardare il mare attraverso un oblò, ma non vidi nulla se non l’acqua che vi sbatteva contro; il resto era un turbinio di spuma grigia e di cenere. Non si poteva distinguere il cielo dal mare…
La nave sobbalzava, si impennava, poi di colpo sembrava di scivolare in un abisso, si scuoteva e cigolava come impazzita. Qualcosa sulla coperta sbatteva violentemente contro le murate.
Ritornai in servizio in sala macchine dando il cambio ad altri stanchi e sfiniti. Quel ritmo bestiale durò tutta la notte, ma le macchine resistevano bene. In quanto a me, non dormii e non mangiai.
Verso il fare del giorno si cominciò a sentire una certa diminuizione della forza del mare e i nostri animi si fecero più speranzosi. Seppi che erano riusciti ad entrare nel locale timone ed avevano bloccato la barra su una posizione fissa. Il rullio della nave, però, sembrava essere aumentato, tanto che si dovette per molte ore, fare un operazione che io non avevo mai né fatto, né visto fare fino ad allora. Consisteva in questo: si doveva manovrare manualmente una lunga leva che chiudeva e apriva repentinamente il flusso del vapore alle macchine e che si doveva sincronizzare ad orecchio con il rumore che l’elica facendo girando a vuoto e che per effetto delle gigantesche onde veniva a trovarsi fuori dall’acqua. (nota del copista: la valvola farfalla si chiudeva quando la motrice precipitava).
La sala macchine era un inferno, ai normali rumori si aggiungevano i continui sobbalzi e scricchiolii della carena, che pareva spezzarsi da un momento all’altro, l’enorme boato che provocavano le onde contro le pareti e tante altre cose che mi facevano sentire come in una fucina infernale.
Erano circa le dieci del giorno dopo ed erano trascorse una ventina di ore dall’impatto con il ciclone. Si incominciava ad intravedere una possibilità di salvezza, in quanto si sapeva che stavamo uscendo dall’occhio del ciclone.
L’atmosfera si era fatta meno cupa fra l’equipaggio, i volti erano meno tesi e qualcuno si permetteva anche qualche battuta spiritosa.
Dalla plancia di comando chiamarono la sala macchine per dirci che era il momento di provare ad entrare nella sala timone per i controlli e la lubrificazione passando, però dall’accesso ordinario che si trovava sopra coperta. Data la pericolosità di tale passaggio per la persona che si sarebbe trovata, anche se per pochi minuti, allo scoperto in balia del mare, si convenne che io sarei andato a fare codesta operazione ma con la scorta di un marinaio.
Mi preparai per l’occorrenza e mi avviai, con una buona dose di paura, verso la porta stagna che dava sulla coperta.
Trovai ad attendermi il marinaio.
Questi era un uomo sui cinquant’anni e fra noi, da quando ci eravamo conosciuti a bordo, c’era sempre stato un rapporto reciproco di stima e di amicizia. Lui mi chiamava con un buffo nomignolo, Totorì, ed io lo chiamavo Zi’ Salvatore per via dell’età, come si usava dalle nostre parti visto che anche lui era un calabrese di Vibo Valentia.
Prima di uscire mi fece molte raccomandazioni come fa un padre con un figlio, ma io vedevo che era molto preoccupato per me. Egli, come d’accordo, mi precedeva. Aprì la porta e fummo fuori. Ci guardammo un po’ intorno, fermi, in attesa del momento propizio per superare quei trenta o quaranta metri che ci separavano dal cassero di poppa.
Quello che vidi fu uno spettacolo indimenticabile: un turbinio di acqua e vento, una luce grigio cenere si potevano intravedere di tanto in tanto enormi onde che mi sovrastavano e mi davano l’impressione di stare in un profondo burrone, di colpo poi ero a cavallo di esse e poi di nuovo giù.
La coperta era spazzata da raffiche di vento e acqua e ogni tanto veniva completamente sommersa da quelle terribili ondate. Vidi un enorme incudine che vagava sbattendo contro i parapetti con il rumore di una cannonata, alcuni fusti di olio anch’essi vacanti e vari altri oggetti. Si poteva vedere una delle due scialuppe completamente fracassata, e ancora un enorme cassone, che di solito conteneva attrezzi, rovesciato su un lato e incastrato fra due vericelli.
Il mio amico scrutava l’aria e mi fece cenno di prepararmi. Al suo via partimmo, io presi di mira il mio più vicino punto d’appoggio, tenendo conto che non avrei potuto raggiungere la meta in un solo colpo. Feci, così una decina di metri e mi aggrappai a qualcosa, un attimo dopo corsi di nuovo verso la meta che sembrava irraggiungibile, ma in quell’attimo vidi un enorme massa scura che dalla mia destra si stava abbattendo sulla nave.
Capii che non ce l’avrei fatta a raggiungere il mio amico che era ormai arrivato alla garretta del cassero, allora lasciai andare l’oleatore che avevo in una mano e mi aggrappai con tutte le mie forze all’albero del vericello di poppa che attraversava la coperta all’altezza di un metro circa. Mi avvinghiai incrociando ad esso gambe e braccia, mi sentii subito sommerso e rimasi così per un tempo che mi sembrò un eternità; poi mi sentii di nuovo libero di respirare e, ancora in quella posizione, potei vedere il mio amico col viso sconvolto che mi chiamava a gran voce ripetutamente e che mi cercava con gli occhi terrorizzati. Egli non aveva potuto vedere la mia azione e quindi pensava che il mare m’avesse portato via. Ricorderò sempre il volto di quell’uomo che ha squarciagola mi chiamava, Totorì! Totorì! E quando vide che ero salvo fu una gran gioia per quel padre che mi voleva tanto bene…
Nei giorni successivi mi disse che non avrebbe più navigato, che si sarebbe ritirato a fare il pescatore con la lampara al suo paese: era stanco di fare quella vita. Infatti così fece, perchè sette anni dopo lo incontrai al suo paese e vidi che era contento poiché viveva decorosamente facendoo il pescatore.
Per giorni navigammo sempre con mare mosso e fu a causa di questo che si sviluppò nelle stive piene di carbone un autoincendio per fortuna domato…
CDM Idamo Rossi – Fuochista – Macchinista 1958